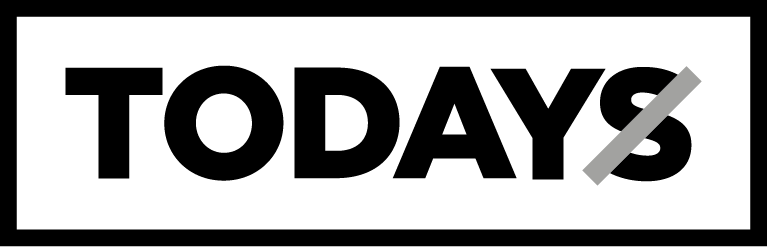LOW
Gli alfieri dello slowcore di Duluth nel loro unico concerto estivo nel nostro paese. La band ha da poco pubblicato il nuovo album in studio, intitolato “Double Negative”, prodotto da BJ Burton e registrato presso lo studio April Base di Justin Vernon (Bon Iver) a Eau Claire, nel Wisconsin. Burton in precedenza ha co-prodotto “Ones e Sixes”, ultimo disco dei Low uscito nel 2015.
Atmosfere malinconiche, unite a melodie soavi e a momenti di stasi trascendente: è la ricetta dei Low, il trio del Minnesota che ha elevato lo slowcore a meditazione spirituale. La musica dei Low non ha eguali nella storia del rock.
Inizialmente emuli di Codeine, Cowboy Junkies e dello slo-core in genere, sono successivamente pervenuti a uno stile personale, minimale nei suoni e trascendentale nell’umore. Nella musica dei Low, voci, suoni, testi e concetti espressi vanno a plasmare un’icona sonora compatta, che trova nella natura il suo referente ma nel superamento della stessa il suo fine. Le atmosfere create sono oniriche, appartengono a mondi lontani, possibili unicamente nei sogni.
Solo Tim Buckley in passato, Roy Montgomery e i Lycia negli anni Novanta sono riusciti a comporre una musica così intensamente metafisica. La poesia sonora dei Low fluisce languidamente, cattura anima e corpo, affascina e rende catatonici, ipnotizza come solo Jim Morrison sapeva fare. Il progetto Low si materializza nel 1994 a Duluth nel Minnesota, e ha come protagonisti Alan Sparhawk (voce e chitarra), la moglie Mimi Parker (batteria e voce) e il bassista John Nichols (sostituito da Zack Sally a partite da Long Division). L’album d’esordio I Could Live In Hope è un lavoro strabiliante, insolitamente maturo per un gruppo alla prima uscita. Il suono è scarno ma intenso; è davvero incredibile come i Low riescano a costruire paesaggi sonori e atmosfere da sogno con la strumentazione classica di una rock band (chitarra, basso, batteria), impartendo così una severa lezione a quella moltitudine di musicisti elettronici che negli anni 90 si vantano di produrre musica ambientale; ciò che ne risulta è una sorta di sussurro etereo che ha la stessa qualità evocativa del vagito celestiale di Elizabeth Fraser. L’arte del trio di Duluth punta a produrre atmosfere; ciò che fa la differenza è che i nostri sanno anche scrivere canzoni.
I Low sono destinati a durare, e con il loro secondo album Long Division, i Low assurgono allo status di classici del rock. Con The Curtain Hits The Cast inizia la fase di transizione, che porterà il gruppo ad esprimersi in un linguaggio più pop. Il sound è più corposo, ispessito dalla produzione di Steve Fisk, e i Low hanno completamente rielaborato le proprie influenze: gli echi di Codeine, Nick Drake e Buckley senior sono stati codificati in uno stile unico, riconoscibile, ormai indipendente dai suddetti modelli. Songs For A Dead Pilot è un disco anomalo in cui i Low producono musica ancora più rarefatta, mentre In The Fishtank è un’interessante collaborazione con i Dirty Three e il violino di Warren Ellis dona più dinamismo al sound dei Low. Secret Name prosegue il discorso iniziato a partire da The Curtain Hits The Cast. Il sound è ancora più corposo per effetto dell’aggiunta di nuovi strumenti come il piano e il violoncello. L”arte dei Low diventa più terrena e meno spirituale: più Neil Young che Tim Buckley.
Things We Lost In The Fire è il successivo capolavoro del trio di Duluth, dove finalmente si fondono tutti gli elementi che hanno caratterizzato, nei diversi periodi, l’universo sonoro dei Low: lentezza, atmosfere celestiali, melodie soavi, intensità del cantato si compiono in strutture armoniche decisamente pop. I Low si riscoprono compositori di canzoni come si facevano una volta (e come si continuano tuttora a fare), con tanto di ritornelli orecchiabili.
Nel 2002 Trust fa di nuovo centro. I Low potrebbero rifare se stessi all’infinito senza annoiare mai. Il sound del trio del Minnesota è il suono dell’uomo che ascende a puro spirito, del fluttuare della piuma mossa dal vento, dell’aurora e del tramonto al tempo stesso: è il suono soul dell’infinito. I Low hanno marchiato a fuoco la storia del rock. Drums And Guns (2007) racconta storie assassine che mescolano candore e amarezza, puntando, come sempre, al firmamento. C’mon esce a ben quattro anni di distanza da Drums And Guns, al culmine di un periodo durante il quale Alan Sparhawk si dedica al parallelo progetto in aria di vintage-rock Retribution Gospel Choir. Registrati nei Sacred Heart Studio di Duluth (siti in una chiesa sconsacrata), dove vide la luce anche Trust, i dieci brani di C’mon risultano canzoni sospese in una dimensione temporale aliena, nella quale tornano a incontrarsi brumose carezze al rallentatore e accorate elegie modellate su scarnificazioni degli stilemi del rock e sulla raffinatezza di melodie tanto eteree quanto compiute. Abbandonata la pur felice strada dell’autoproduzione, per The Invisible Way (2013) i Low hanno deciso di chiamare in cabina di regia tale Jeff Tweedy dei Wilco, il quale ha risposto ospitando i giganti dello slowcore nel contesto ideale (il Wilco Loft di Chicago) in cui scrivere l’ennesimo capitolo memorabile della propria storia.
Con Ones And Sixes (2015) l’elettronica rientra nel mondo dei Low, ma questa volta dalla porta d’ingresso, senza intaccare il costante fascino spartano e naif della band. Gelido, aspro, rigido a tratti desolato il nuovo album contiene più di un elemento per restare in piedi al di là della fama e della storia del gruppo. L’elettronica è invece usata in modo diametralmente opposto sul nuovo album Double Negative (2018), dove i suoni sintetici non servono ad arricchire, ma a distruggere. Confermato BJ Burton in cabina di regia, gli viene lasciata carta bianca e un’unica, sadomasochistica istruzione: picchiare per far male. E’ pertanto un diverso immaginario elettronico, cupo e nichilista, a riempire l’orizzonte: dubstep, glitch, post-club music, industrial, qualche goccia di trip hop giusto per diluire un composto così micidiale da rischiare la detonazione prima del dovuto. La sensazione è straniante: è come se uno psicopatico in preda ad una crisi fuori controllo si fosse messo a remixare qualche loro vecchio album, magari servendosi di una strumentazione in avaria. E’ l’altro lato dello scintillante sogno accelerazionista, una visione catastrofica che esaspera la tecnologia per farla collassare su se stessa, un grido così lacerante che si soffoca da solo. Il “doppio negativo” del titolo va quindi interpretato non solo come orrore da fronteggiare qui e ora, ma anche nel senso di negativo fotografico, ribaltamento dimensionale che inverte i colori e svela il rimosso.
Quello dei Low è un sacrificio quasi cristologico, un attirare su di sé il Male per trascinarlo nella propria scomparsa, accettare di farsi divorare per liberare il mondo da una sofferenza insostenibile e immotivata. Nessuna facile tentazione millenarista, tuttavia: solo tanto, impotente, umanissimo dolore. In una scena di “You May Need A Murderer”, imperdibile documentario del 2007 in cui i coniugi Sparhawk mettono a nudo i propri spettri, Alan dice una cosa del tipo “come dovrei comportarmi se il mio Dio mi chiedesse di fare del male?”. Nell’impossibilità di sciogliere un quesito così atroce, Double Negative tenta quantomeno di sfogarne il tormento in una catartica tabula rasa, un potlatch in cui scaraventare ciò che si ha di più caro solo per vederlo bruciare. Lo slowcore degli esordi, il folk-rock della maturazione e l’avant-pop dell’età adulta sono solo sbiaditi ricordi nella mente di un suicida spirante, e Double Negative è precisamente questo: un harakiri artistico, il loro disco più estremo e una delle opere più sconvolgenti degli ultimi anni.